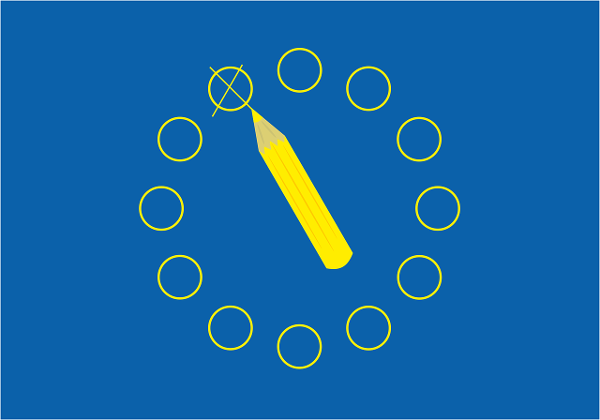Qualcosa deve cambiare nell’architettura istituzionale dell’Unione economica e monetaria europea. Questo è un mantra che, da un po’ di tempo a questa parte, pare aggirarsi nelle opinioni pubbliche europee e nelle menti di un ampio gruppo di intellettuali continentali. L’esito della crisi dei debiti sovrani (con l’esplodere del caso Grecia, tra tutti) già aveva segnato, infatti, una breccia in un blocco monolitico di intendere lo sviluppo della governance economica sovranazionale (che proprio, per nemesi, in risposta a quella crisi aveva subito un massiccio irrigidimento). La crisi COVID-19 ne ha accelerato il bisogno storico nel senso di un urgente processo di riforma. Quello che non è chiaro, però, è se, in seno alle istituzioni UE, sia maturata la consapevolezza della necessità di un tale intervento. La sospensione del Fiscal Compact, tramite l’applicazione della clausola generale di salvaguardia fino al 2022 (o forse fino al 2023), rappresenta, per ora, solo un segnale (significativo ma non inequivocabile) di un possibile “ripensamento in corso”. Nulla impedisce, però, di immaginare il contrario: ovvero, una sorta di nuova restaurazione post COVID-19 dell’ Ancien Régime di sorveglianza economica.
Date queste linee di contesto, quello che mi interessa svolgere in queste righe è, però, una più piccola riflessione su una (delle tante) recenti proposte di cambiamento delle EU Fiscal Rules, che porta la prima firma di Olivier Blanchard (ex capo economista del FMI), e che è testimonianza granitica – dalla prospettiva di un certo gruppo di élites del mainstream economico – di un tentativo di risposta a quel mantra. L’analisi parte da due dati di fondo: (1) un’incapacità storicamente provata dell’attuale governance economica di rispondere alle crisi (rendendo difficoltoso l’utilizzo di strumenti anticiclici); (2) un netto cambio di contesto che interesserà il mondo post COVID-19, in cui si accentuerà il prolungamento di alti livelli di debito e tassi di interesse molto bassi per il finanziamento di questo.
La tesi è, dunque, che il sistema così come disegnato oggi è inefficace poiché, in prima battuta, il suo grado di complessità fatto di regole dettagliate sulla sostenibilità del debito provoca farraginosità e, in seconda, perché il sistema di enforcement (tutto incardinato nel rapporto Commissione-Consiglio) risulta ad oggi poco credibile, soggetto qual è alle dinamiche politiche di “contrattazione” tra governi nazionali e istituzioni sovranazionali. La proposta di modifica, dunque, isola questo asse regola + enforcement tecno-politico, eleggendolo a cuore del problema, e sostiene un vero e proprio rovesciamento, che garantirebbe una maggiore funzionalità della governance economica europea: il passaggio a standard + enforcement giudiziario.
Con il passaggio allo standard e grazie alla sua maggiore flessibilità rispetto alla regola, si otterrebbe – a parere di Blanchard e co. – il doppio risultato di allargare le maglie dell’autonomia della politica fiscale degli Stati e di focalizzare l’attenzione non su singole voci di spesa ma sul solo dato cumulativo. In questo senso si riempirebbe in un sistema a cascata – composto di fonti derivate e atti non vincolanti – di nuovo contenuto l’art. 126 del TFUE (“Gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi”) che guarderebbe non a parametri economici rigidi, ma si avvarrebbe della cd. Stochastic Debt Sustainability Analysis. La scelta di questo nuovo strumento sta in un elemento: la maggiore adattabilità al contesto macroeconomico, riconoscendo esplicitamente a contrario l’incapacità strutturale di un (seppur) sofisticato mix di regole di definire propriamente il concetto stesso di sostenibilità del debito che si caratterizza per un altissimo grado di incertezza.
Le regole non sono capaci di svolgere questo compito, lo standard, si. Dimostrazione del fatto, dunque, che anche in un riconosciuto alto grado di incertezza, la variabile del debito è pur sempre catturabile da “neutri” meccanismi di sorveglianza. “Neutri” ma non neutrali, perché pur sempre attenti a preferire variabili la cui scelta e ponderazione non è oggettiva (ma sono frutto di un acceso dibattito, come sull’output gap) e a portare alla determinazione di una politica economica basata sul solo lato dell’offerta. Ovvero, costruendosi sempre nella logica di una soft austerity e di una correzione dei cd. democracy failures, senza mettere in campo una proposta che contempli di affrontare in UE quello che sarà il vero nodo dirimente post COVID-19: il rapporto asimmetrie/redistribuzione. Per Blanchard e co. la sostenibilità del debito resta pur sempre una variabile tecnica, non politica, insomma.
Ma è sull’enforcement giudiziario che voglio soffermare maggiormente l’attenzione. La scelta di assegnare l’enforcement delle regole fiscali europee ad una sezione specializzata della Corte di giustizia fa riflettere. Blanchard stesso esclude che la sola mano invisibile del mercato possa svolgere un ruolo sufficiente di controllo e, per questo motivo, manifesta infatti un forte favore verso l’introduzione in questo settore di un soggetto indipendente, che si occupi di garantire un hard enforcement.
Si direbbe: allargando le maglie dalle regole agli standard, è ragionevole pensare di richiedere un “credibile” meccanismo di controllo, pena l’inconsistenza della proposta. Ma si potrebbe obiettare: ma il fine non era garantire un maggior margine di azione alla politica economica degli Stati membri? Cambiando l’ordine degli addendi (cioè ampliando, da una parte, attraverso la flessibilità dello standard, si toglie, dall’altra, introducendo l’univocità della decisione giudiziaria) il risultato non cambia. E, anzi, l’affidamento esclusivo alla Corte di giustizia dell’enforcement rischia non solo di lasciare tutto così com’è, ma di aggravare la disciplina di bilancio.
Per dirla in maniera ancora più chiara, vi sono due obiezioni a questa scelta: (1) l’esito che potrebbe ingenerare una giurisdizionalizzazione di questo campo rischierebbe di provocare un effetto gattopardesco, secondo cui le maglie di manovra fiscale si restringono invece che ampliarsi, viste le specifiche caratteristiche strutturali del circuito giudiziario, basate sull’obbligo di decidere (divieto di non liquet) e sulla logica dell’aut-aut (annichilendo, così, i margini di mediazione politica); (2) dare mandato alla Corte di giustizia di dirimere i conflitti derivanti dalla political issue per eccellenza (il potere di spesa!) – e non volerla riconoscere come questione democratico-rappresentativa – va nel verso di un’ulteriore sovra-costituzionalizzazione e depoliticizzazione dell’UE, da alcuni considerato il principale male del processo di integrazione. Invece di passare dagli attuali scontri Commissione/Consiglio vs. Stato, a dei più auspicabili conflitti redistributivi nello spazio pubblico europeo, la direzione è, in definitiva, di rinviare il contenzioso a forme di giustizia ex post.
Questo, d’altra parte, è un classico espediente che in Unione viene riproposto all’acuirsi dei conflitti costituzionali e che sembra voler nascondere sotto il tappeto i veri problemi. Non sarebbe, certo, la prima volta (vedi la realizzazione dell’Internal Market): ma il pericolo che si corre è quello di un ennesima restrizione dello spazio di contestazione di scelte che sono politiche, a tutti gli effetti.
Un’ultima postilla, poi, sul “non detto” di tale proposta: non includere in questa riflessione il ruolo della BCE e non prendere atto del suo attuale ruolo espansivo di acquirente di ultima istanza (la reale garanzia di sostenibilità dei debiti sovrani!) può far pensare – ai maliziosi – che l’idea di fondo di tale proposta sia ri-organizzare un ritorno ordinato all’era pre-COVID 19, in cui, attraverso una presupposta maggiore ampiezza della disciplina di bilancio, si incentivi un ritorno della Banca centrale al suo vecchio ed esclusivo ruolo di garante del cd. moral hazard; e, contestualmente, si immagini solo il MES come strumento di assistenza finanziaria, con tutto il suo bagaglio di ricche condizionalità – dal sapore calvinista – a tutela delle ragioni del creditore.
Si potrebbe sostenere a contrario: non si considera, sufficientemente, il ruolo del Next Generation EU. Si potrebbe rispondere: se questo rappresenta una rottura del dogma del divieto di indebitamento dell’UE ed è sicuramente una nota positiva da non sottovalutare perché garantisce dei margini di redistribuzione, c’è da considerare anche che è (1) una misura costruita per essere una tantum; (2) di mole, secondo alcuni, ridotta rispetto alle reali necessità della crisi (vedi il paragone della politica di Biden negli USA); (3) che manifesta una tendenza proto-federale, ma non necessariamente democratica, nell’individuazione delle principali traiettorie di spesa per il futuro dell’UE, su cui le società europee poco o nulla hanno avuto da dire. Il reale impatto di questo strumento è tutto da scoprire, in fin dei conti, da guardare con il pessimismo della ragione e l’ottimismo della volontà.
Giunti alla conclusione, è evidente dunque come toccando un pezzo del puzzle, si ingeneri il più classico degli effetti domino e questo non può non rientrare nell’analisi. Focalizzandosi, tuttavia, sulla proposta di Blanchard e co. quello che non convince, insomma, è l’impostazione di fondo: la politica economica non può essere lasciata ad una regolamentazione manageriale e ad una guida tecnocratica. Questo proprio perché il rischio sempre più evidente – ad un occhio attento che abbraccia un europeismo non à la carte – è una lenta e disordinata deflagrazione della zona euro nel contesto post COVID-19, in mancanza di interventi strutturali che guardino all’insieme dell’architettura istituzionale dell’UE e che vadano nella direzione di garantire un controllo politico dell’economia e forti capacità redistributive. Quello di cui ci sarebbe bisogno, in altri termini, per dirlo con una formula un po’ âgée, è andare nel verso di un governo democratico dell’economia. Per far ciò, però, è necessario un salto di qualità. Il dilemma rimane, perciò, il seguente su questi temi: semplice riforma o radicale trasformazione?
L’UEM: e pur si muove! Ma verso quale direzione?