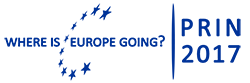L’ordinamento costituzionale bosniaco emerge nel delicato contesto della dissoluzione dell’ex-Jugoslavia, avvenuta a partire dal 1991. Nel marzo 1992, anche la Bosnia-Erzegovina ha dichiarato la propria indipendenza in seguito a un referendum, richiesto dalla Comunità Europea, che fu però boicottato dalla parte serba della popolazione. Dopo l’indipendenza, in Bosnia-Erzegovina si scatenò un efferato conflitto che vide drammatiche operazioni di pulizia etnica e genocidi, oltre che il lungo assedio della città di Sarajevo. Durante la guerra, si configurarono le due entità territoriali che tutt’ora compongono l’ordinamento bosniaco. Già il 9 gennaio 1992 era stata dichiarata l’indipendenza della cosiddetta “Repubblica serba di Bosnia-Erzegovina” (Republika Srpska), guidata dai leader nazionalisti serbo-bosniaci, senza che tale dichiarazione fosse stata però dichiarata valida dal governo centrale. Nel 1994, invece, con la firma degli Accordi di Washington, fu istituita la Federazione della Bosnia-Erzegovina a maggioranza bosgnacca-croata, ulteriormente suddivisa in dieci cantoni.
Gli Accordi di Dayton del 1995 posero fine al conflitto e andarono a delineare un’architettura costituzionale molto complessa, fondata su principi consociativi e federali. Dal punto di vista dell’organizzazione territoriale del potere, la Costituzione di Dayton riconosce le due unità territoriali (Federazione e Republika Srpska) come entità che compongono lo Stato, a cui si aggiunge il Distretto autonomo di Brčko. Ciascun livello di governo (Stato centrale, entità, cantoni della Federazione, Distretto di Brčko) sono dotati di un proprio esecutivo, assemblea legislativa e sistema giudiziario. La Costituzione attribuisce allo Stato limitate competenze esclusive, mentre alle entità ampie competenze residuali. La struttura federale delineata da Dayton si fonda quindi su un livello centrale molto debole e su due entità sub-statali molto forti, con ampi poteri ed autonomia. L’intero ordinamento costituzionale si fonda sul riconoscimento, nel preambolo della Costituzione, dei tre “popoli costitutivi” (bosgnacchi/musulmani, croati, serbi), distinti dai cosiddetti “altri”, ossia le minoranze nazionali e chi non si identifica con i popoli costituivi. La Costituzione di Dayton prevede che solo i popoli costitutivi siano titolari di diritti collettivi e possano condividere il potere nelle istituzioni politiche dello Stato centrale, dando vita a una presidenza tripartita e un’assemblea parlamentare bicamerale, elette su base etnica e territoriale. Gli “altri” sono attualmente rappresentati solo in una delle due camere (la camera dei rappresentanti), eletta su base territoriale e non etnica (come invece la seconda camera - la camera dei popoli - e la presidenza).
Nel contesto della transizione costituzionale della Bosnia-Erzegovina, la Corte costituzionale ha svolto un ruolo fondamentale. Dopo una prima fase di rigida applicazione del modello introdotto da Dayton, che aveva portato di fatto alla segregazione etnica dei tre popoli costituitivi all’interno del territorio, con la storica sentenza dei popoli costitutivi del 2000 (caso U-5/98-III, 1° luglio 2000) la Corte costituzionale ha aperto una nuova fase della transizione. Infatti, la Corte non solo ha impresso una direzione multietnica all’ordinamento, riconoscendo lo status paritario dei tre popoli costitutivi all’interno dell’intero territorio e non solo nelle entità dove erano in maggioranza, ma ha anche stabilito chiaramente che le due entità sono da considerarsi entità sub-statali e non Stati sovrani. La Corte pertanto sembra delineare una struttura federale e non confederale, oltre che ribadire la supremazia della Costituzione bosniaca sulle costituzioni e sulle leggi delle due entità sub-statali.
Nel corso dell’evoluzione dell’ordinamento, la Corte ha continuato a svolgere un ruolo fondamentale, rinforzando progressivamente il livello centrale. In particolare, la Corte ha delineato una serie di competenze concorrenti, imprimendo una direzione cooperativa a un federalismo inizialmente di tipo duale. Inoltre, la Corte ha riconosciuto l’esistenza di un quadro comune all’interno del quale si articolano competenze concorrenti in materie quali la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali (caso U-1/11, 13 luglio 2012). Il rinforzamento del carattere multilivello dell’ordinamento bosniaco è ancora più rilevante se si considera il percorso di integrazione europea, iniziato nei primi anni Duemila e che dal 2022 vede la Bosnia-Erzegovina come Paese candidato. Nel 2019, la Commissione Europea ha identificato una serie di priorità fondamentali che la Bosnia-Erzegovina deve soddisfare per raggiungere la piena adesione. Tra queste, la priorità n. 4 riguarda il miglioramento dell’assetto istituzionale al fine di assicurare una chiara distribuzione delle competenze tra il livello centrale e le entità.
A tal proposito, due casi arrivati davanti la Corte costituzionale sono emblematici nel far emergere tutte le difficoltà che la Corte (e l’ordinamento nel complesso) sta attualmente affrontando. Nel 2021, l’assemblea nazionale della Republika Srpska ha adottato una serie di decisioni che prevedevano il trasferimento unilaterale di una serie di competenze dallo Stato centrale alle entità. Tali competenze erano state precedentemente trasferite dalle entità allo Stato centrale nei primi anni Duemila secondo una serie di accordi tra Stato ed entità, opzione prevista dalla Costituzione e precedentemente confermata dalla Corte (caso U-11/08, 30 gennaio 2009). Le decisioni sono state subito impugnate davanti alla Corte, che ne ha dichiarato l’incostituzionalità nel 2022 (caso U-2/22, 26 maggio 2022) confermando che le entità non possono unilateralmente revocare il proprio consenso da un accordo sul trasferimento di specifiche competenze allo Stato centrale.
Qualche mese dopo, la Republika Srpska ha adottato una legge sulla registrazione degli immobili, dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale per ben due volte (caso U-10/22, 22 settembre 2022; caso U-5/23, 2 marzo 2023). In entrambe le decisioni, la Corte ha confermato che la proprietà pubblica ricade sotto le competenze esclusive dello Stato centrale e non delle entità. È opportuno notare che le autorità della Republika Srpska, quando la legge è stata impugnata, avevano immediatamente dichiarato che non avrebbero rispettato la decisione della Corte costituzionale. Ciò è effettivamente successo quando, dopo la prima decisione della Corte, la legge è stata ugualmente pubblicata nella gazzetta ufficiale dell’entità, portando quindi a una nuova impugnazione e successivamente a una nuova sentenza di incostituzionalità.
Pertanto, per quanto la Corte abbia svolto un ruolo cruciale nell’evoluzione del federalismo bosniaco in senso integrativo, nel tempo essa ha visto un sostanziale indebolimento della propria autorità. Già nel 2010 e nel 2015, infatti, la Corte ha visto importanti sentenze non rispettate (caso U-9/09, 26 novembre 2010; caso U-3/13, 26 novembre 2015), andando a minare i principi dello Stato di diritto. Come visto, negli ultimi due anni la Republika Srpska ha più volte dichiarato apertamente che non avrebbe rispettato le decisioni della Corte, fino ad adottare nel giugno del 2023 una decisione secondo cui l’autorità della Corte non viene riconosciuta nell’entità.
Inoltre, è bene osservare che uno dei punti dirimenti nella complessità dell’ordinamento bosniaco è che non c’è una visione condivisa del futuro dell’ordinamento, anche dal punto di vista dell’organizzazione territoriale. La parte bosgnacca, forte della propria maggioranza, è orientata verso un ritorno a uno Stato centrale più forte, andando a ridimensionare l’autonomia delle entità territoriali. La parte croata, per difendere la propria posizione di minoranza, sostiene la creazione di un’entità croata separata dalla Federazione e l’istituzione di un assetto propriamente federale. La parte serba, infine, continua a minacciare la secessione dalla Bosnia-Erzegovina e sostiene politiche di maggiore autonomia per le entità, in chiave confederale.
In conclusione, è interessante notare come gli sforzi di maggiore integrazione interna da parte della Corte, anche al fine di un’efficace applicazione delle norme europee una volta che il Paese aderirà all’Unione, hanno recentemente generato un effetto disintegrativo, in quanto la Republika Srpska ha usato politicamente le sentenze della Corte per non riconoscerne l’autorità e per avanzare le proprie rivendicazioni politiche in chiave secessionista.
Per rimanere aggiornato sulle novità di EUblog iscriviti alla Newsletter